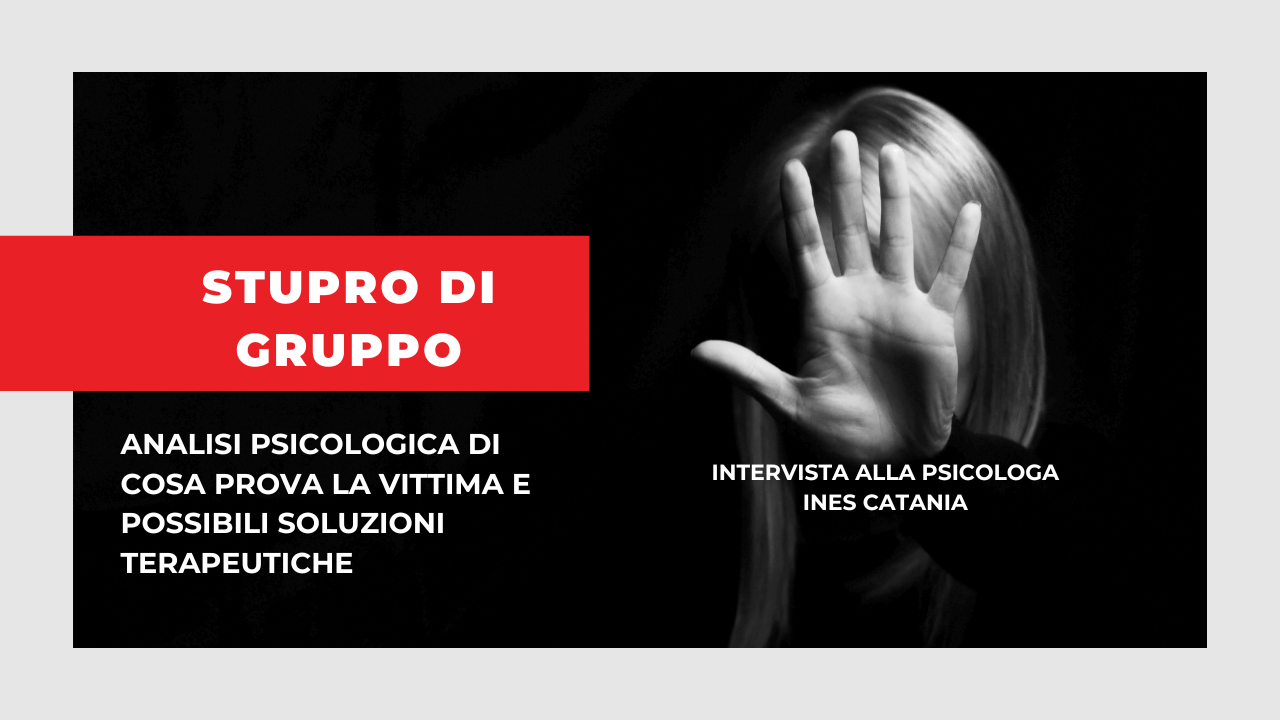PALERMO – Dietro uno stupro, per chi lo subisce, c’è un mondo. Un susseguirsi di pensieri, paure, incomprensioni, rabbia e tanto dolore.
La violenza sulle donne, infatti, non è solo sopraffazione, è molto di più: è non riconoscere loro alcuna identità umana e specifica realtà psichica.
Il pensiero “malato”
Le donne sono per molti uomini solo oggetto di possesso, adibite alla procreazione e alle cure familiari. “Per giustificare questo pensiero ‘malato’, cioè non aderente alla realtà, si attribuisce la responsabilità dei crimini degli stupri e abusi alle donne stesse che sarebbero colpevoli di seduzioni svianti, di costumi inappropriati e di esigere la propria libertà“, spiega la psicologa Ines Catania intervenuta ai nostri microfoni.
Insomma “il male” sarebbe nel genere femminile, che non avendo alcuna razionalità, necessiterebbe di un controllo maschile e sociale. È un pensiero delirante che ci portiamo dietro da millenni che impedisce una reazione corretta e una trasformazione culturale.
Ed è quello che è successo poco tempo fa nello stupro di gruppo a Palermo che, ancora una volta, ha visto vittima una giovane donna.
Si può superare e dimenticare uno stupro?
Adesso, ci si chiede come questa 19enne potrà affrontare questo dolore e come e con quale spirito la famiglia possa aiutarla.
Per questo motivo la psicologa ci ha ricordato le parole di una famosa lettera che un padre, il padre della ragazza stuprata a Roma, scrisse per descrivere il male di vivere della figlia:
“Nei momenti più bui mia figlia aveva evocato il desiderio di farla finita, e la notte si sente più sola; lo sai che ha fissato il vuoto dalla finestra come una tentazione. E poi gli psicofarmaci e il loro suadente stordimento. Conquista la Maturità e anzi la competitiva ammissione a un collegio universitario di merito. Vuole studiare anche per proteggere altri da quello che è successo a lei: sceglie giurisprudenza, per diventare Procuratore. Ma la prima notte nel collegio, da sola fra estranei, la riassale la paura paralizzante. Ora non c’è scelta: ospedale psichiatrico. Duri mesi ipermedicata, ma è forte. Chiede di essere non solo una paziente ma anche una collaboratrice: impara molto e termina la degenza. Ormai l’anno accademico è perso, e vuole imparare di più: entra volontaria in un rifugio per donne vittime di violenza“.
Da queste parole, soprattutto “entra volontaria in un rifugio per donne vittime di violenza“, è chiaro che il trauma non si può cancellare ma “si può dare un nuovo significato funzionale per la vittima, per la famiglia e per la società“, suggerisce la nostra intervistata.
Dalla parte della vittima: che cosa prova?
Ma facciamo un passo indietro. Chiariamo quale sia il meccanismo psicologico che si innesca dopo aver subito una violenza simile. Doveroso parlare di DPTS (disturbo post traumatico da stress).
Chi ha a che fare con donne che hanno subito maltrattamenti, sa che si tratta di persone che hanno una condizione molto particolare, caratterizzata dalla confusione, dalle contraddizioni, dalle assurdità e dal tentativo di tenere insieme livelli di complessità molto elevati.
Le donne maltrattate, poi, hanno personalità “difficili”, sono costrette a far valere il proprio punto di vista contro tutto e tutti, reagiscono aggressivamente alle situazioni, alle relazioni e alle critiche.
Il disturbo post traumatico da stress
La nostra intervistata ha spiegato – provando a entrare nella testa della vittima – quello che sta provando la 19enne dal punto di vista psicologico dopo che il fattaccio è stato compiuto, dopo che la sua dignità di donna è stata lesa, quasi per sempre.
“Il DPTS consiste nel rivivere l’evento traumatico: il soggetto presenta ricordi intrusivi (flashback) dell’evento, sogni ricorrenti e sgradevoli. Quando il soggetto viene esposto ad eventi simili sperimenta forte disagio:
- Evitamento degli stimoli associati al trauma: il soggetto si sforza di evitare pensieri, sentimenti o conversazioni che riguardano l’evento traumatico, oppure attività o persone che sollecitano il ricordo;
- Ottundimento della reattività generale: dopo l’evento traumatico inizia una riduzione della reattività verso il mondo esterno, una sorta di paralisi psichica o emotiva. Il soggetto può soffrire di un ridotto interesse verso attività precedentemente piacevoli, oppure di un senso di distacco o estraneità a situazioni o persone. Diminuisce anche il senso di prospettiva futura;
- Aumento dell’arousal (eccitabilità): il soggetto presenta sintomi persistenti di ansia ed eccitazioni non presenti prima del trauma.
Questi sintomi possono comportare disturbi del sonno, situazioni di ipervigilanza ed esagerate risposte di allarme, stati di ira e irritabilità, difficoltà a concentrarsi“.
Un disturbo che causa un disagio
Il disturbo causa, pertanto, “un disagio clinicamente significativo o una menomazione del funzionamento sociale, lavorativo o di altre aree importanti della vita quotidiana, perciò il limitato funzionamento delle donne che subiscono violenze e maltrattamenti è una condizione strutturale, che rientra nel quadro sintomatologico del trauma“.
Nel caso degli eventi stressanti di tipo interpersonale, come la violenza domestica, è abbastanza comune osservare un quadro caratteristico con “compromissione della modulazione affettiva, comportamento autolesivo e impulsivo, sintomi dissociativi, lamentele somatiche, sentimenti di inefficienza, di vergogna, di disperazione o di mancanza di speranza, sentirsi irreparabilmente danneggiati, ostilità, ritiro sociale, sensazione costante di minaccia, compromissione delle relazioni con gli altri, o cambiamento delle caratteristiche di personalità“.
Come se non bastasse, “il trauma o disturbo post traumatico da stress è spesso correlato e/o seguito negli anni da altri disturbi d’ansia o dell’umore anche di pesante portata“.
“Alla base del trauma vi è l’impossibilità di costruire un significato coerente e per recuperare una dimensione di benessere è fondamentale l’integrazione e la rielaborazione di tale significato rispetto all’esperienza vissuta“, ribadisce la psicologa.
La possibile soluzione terapeutica
Abbiamo compreso dalle parole della nostra intervistata che “quando un soggetto è traumatizzato sperimenta un’interruzione nel senso di continuità del sé, uno stato di allerta, come se il pericolo fosse presente anche se non lo è più, ha la sensazione che l’evento stia riaccadendo nel qui e ora ed è questo che crea tanta destabilizzazione“.
A questo punto ci si chiede: cosa si può fare?
“Da psicoterapeuta ericksoniana ‘convinta’ (dai risultati ottenuti dai pazienti con dpts), l’ipnosi e la psicoterapia ericksoniana rappresentano un’importante risorsa terapeutica che consente alla vittima di trauma un’opportunità per elaborare le emozioni, le sensazioni, le credenze disfunzionali associate al vissuto traumatico“, consiglia.
Ma “intraprendere una psicoterapia associata alle tecniche ipnotiche non equivale a eliminare dei file mentali associati all’episodio traumatico, come prima dicevo, ma consiste nell’attivazione di una adeguata rielaborazione, che consente di integrare i vissuti gravosi del passato in modo tale da disinnescare il loro condizionamento sul presente“.
L’ipnoterapia: come funziona e i benefici per la vittima
Difatti, “secondo Erickson, l’ipnoterapia va considerata come un processo mediante il quale aiutiamo le persone a utilizzare le loro associazioni mentali, ricordi e potenzialità vitali per raggiungere il proprio scopo terapeutico, attraverso la Co-costruzione di uno spazio esperienziale senso-motorio complesso, l’attivazione deliberata dei sistemi motivazionali e attraverso l’Attivazione deliberata della dissociazione“.
“Non si tratta di una semplice relazione terapeutica, ma di una particolare interazione tra individui che modifica la strutturazione della coscienza che noi, psicoterapeuti ericksoniani chiamiamo Rapport“, spiega.
Una buona e mirata psicoterapia ericksoniana sarebbe utile anche per i genitori delle vittime che sperimentano un pesantissimo vissuto di fallimento come educatori, di frustrazione e di dolore acuto.
“Indirizzarli a perdonarsi laddove credono di aver fallito, rielaborare i sentimenti negativi che provano e ricostruire un significato funzionale. Aiutarli per poter aiutare! Supportarli per fare in modo che possano essere validi pilastri per i loro figli!“, conclude.