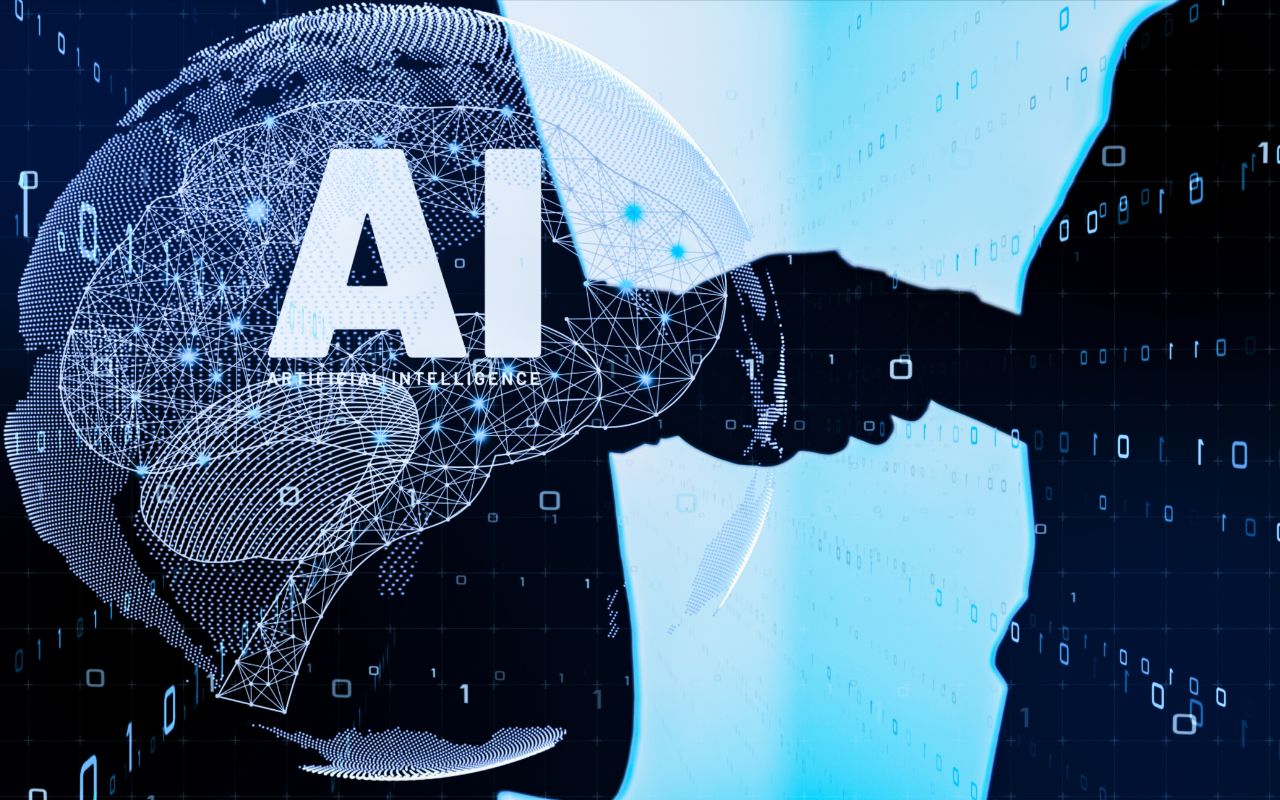Sopravvalutare l’intelligenza artificiale dando per scontata quella umana. È indubbiamente questo uno dei più grandi rischi della società odierna, caratterizzata dall’uomo che delega ad altri qualsiasi attività che richieda una quantità “eccessiva” di tempo o di impegno. E se delegare a qualcuno il ritiro di un pacco, una pratica burocratica o semplicemente di andare a prendere il figlio a scuola può alleggerire il proprio carico giornaliero senza troppe conseguenze, fare lo stesso con le proprie funzioni cognitive implica rischi di ben altra natura. Quello maggiore è la possibilità di “disabituare” il proprio cervello a pensare, ragionare, programmare e, in primo luogo, a sentire, percepire, intuire. Probabilmente le uniche abilità – quest’ultime – che non rientrano nell’interminabile lista di funzioni che i chatbot – al giorno d’oggi spesso (ab)usati – sono in grado di soddisfare.
Ma com’è possibile che l’AI, realizzata per somigliare alla mente umana, adesso diventi invece il prototipo su cui l’uomo sceglie di modellarsi, col rischio di snaturare la propria figura?
Il “costo cognitivo” dell’intelligenza artificiale: la parola alla dott.ssa Pollicino
È importante a questo punto comprendere in che modo l’uomo, colui che ha insegnato alle “macchine” a pensare, può arrivare a compromettere la sua capacità di farlo, andando incontro a una forma di deterioramento cognitivo.
Per capire quali sono i pericoli concreti, che sicuramente un uso responsabile dell’intelligenza artificiale riduce notevolmente, la dottoressa Carla Pollicino, psicologa e psicoterapeuta, è intervenuta ai nostri microfoni.
- Quali possono essere, a livello cerebrale, le conseguenze a breve e lungo termine dell’uso dell’intelligenza artificiale nello svolgimento delle attività quotidiane?
“Le conseguenze dipendono dall’uso che si fa dell’intelligenza artificiale ovvero – spiega la dott.ssa Pollicino – dal fatto che questa possa essere usata come un ‘supporto‘ o come un ‘sostituto‘ allo svolgimento di alcune attività quotidiane.
L’AI fornisce risposte rapide a varie problematiche (per esempio compiti, formulazione di messaggi) e questo rappresenta oggi un grande vantaggio se si considera la società in cui viviamo in cui predominano i ritmi frenetici e il “mito del fare”, secondo cui ‘più cose riesco a fare in una giornata, più valgo‘.
Nel lungo periodo però – e se le risposte fornite dall’AI vengono sempre prese per ‘buone’ – questo può portare a inibire le funzioni esecutive che ci consentono di elaborare le informazioni in modo più accurato e mettere in atto, di conseguenza, specifici comportamenti, come mantenere l’attenzione su un compito importante senza farsi distrarre da altri stimoli“.
- Qual è l’impatto a livello cognitivo di un cervello sempre meno “allenato” a compiere sforzi e a elaborare un pensiero critico?
“Le conseguenze di un uso passivo e continuativo dell’AI – approfondisce la psicologa – possono portare a una ‘pigrizia cognitiva‘, cioè alla tendenza ad affidarsi all’AI nello studio e nella ricerca di soluzioni a problemi. Ciò può portare ad una diminuzione della motivazione intrinseca nello svolgimento di un compito, alla diminuzione del pensiero critico, del pensiero creativo e delle capacità decisionali“.
- Quanto influisce l’utilizzo precoce dell’AI nei bambini?
“L’uso della tecnologia in generale e dell’AI nei bambini – aggiunge – ha un impatto significativo nel loro sviluppo cognitivo ed emotivo per cui andrebbe sempre regolamentato e supervisionato dai genitori e dagli insegnanti. Affinché gli effetti negativi dell’abuso di queste tecnologie, come visto anche negli adulti, non impattino sui bambini nei termini, ad esempio, di disattenzione, scarsa tolleranza alla frustrazione e difficoltà relazionali è necessario che questi vengano educati e formati a un uso consapevole di questi strumenti“.
- Come trovare un equilibrio tra la “comodità” fornita dalle risposte rapide ed esaustive dei chatbot e la necessità comunque di un’impronta “umana” nelle attività svolte?
“L’equilibrio è possibile e, come dicevamo all’inizio, dipende dalla consapevolezza con cui viene usato questo strumento. Per fornire delle risposte valide l’AI richiede un prompt chiaro e ben definito e riuscire a formularlo non è così scontato. Bisogna quindi riflettere su cosa si vuole chiedere, sul perché e su come poterlo chiedere in modo efficace. Inoltre le risposte ricevute devono essere considerate come ipotesi da verificare, così come le fonti che vengono citate, ed è necessario integrarle con informazioni ricavate con altri strumenti e dal confronto con gli altri.
L’AI non è da considerare un sostituto delle modalità classiche di apprendimento ma – conclude – un’integrazione a queste. Solo così è possibile garantire l’indipendenza cognitiva e lo sviluppo dell’individuo“.
L’intelligenza umana che prende per mano quella artificiale
E quindi forse a fare la differenza, in un mondo in cui “correre” è la regola, è colui che di tanto in tanto sceglie di fermarsi a riflettere e ragionare, forse non con la stessa rapidità ed efficienza dell’AI, ma piuttosto con l’originalità e l’autenticità di un pensiero che nessun sistema al di fuori della mente umana è, e probabilmente sarà mai, in grado di offrire.