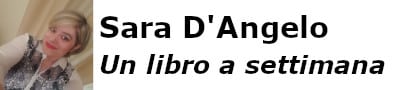La pianificazione di un romanzo alleato con la letteratura d’autore è una costante di Paolo Nori. Uno stile noto ai suoi lettori abituati a un sottotitolo invisibile acquisito da altre, più o meno coetanee firme di valore. I riferimenti nelle opere di Paolo Nori sono maturati dagli incontri con i padri della letteratura dai quali ricava ispirazione fiera della comunione con il fascino intellettuale.
Con il romanzo vicino agli itinerari esplorativi di un saggio Mondadori pubblica “Chiudo la porta e urlo” di Paolo Nori, scrittore avvezzo ad appartarsi nel suo personalissimo alone di vivace curiosità intellettuale. L’opera finalista al Premio Strega 2025 si discosta e non poco dalle aspettative di un lettore educato al ritmo “familiare” di un romanzo.
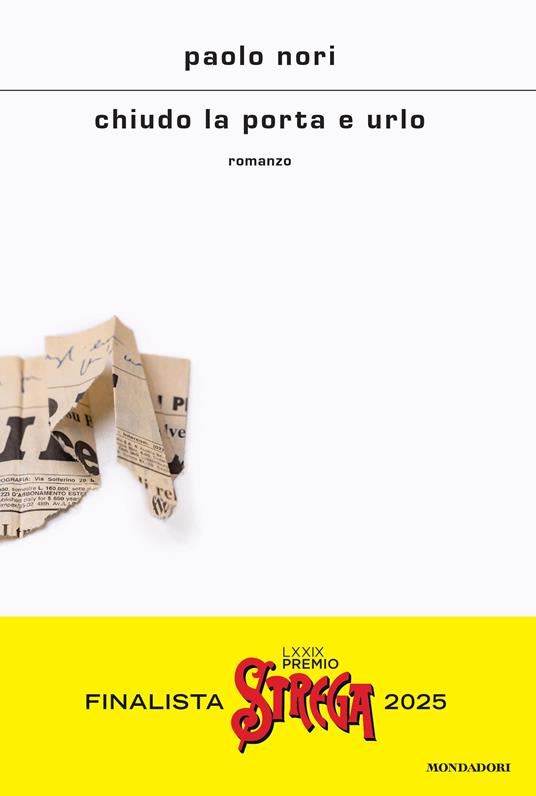
Credit Google/Ibs
Nori scrive di Baldini. Due cognomi affiatati per tutto il fruscío di pagine votate all’accoglienza di passato e futuro della letteratura italiana.
Raffaello Baldini (1924-2005) scrittore e poeta nato a Santarcangelo di Romagna, entra nel romanzo su invito di una sfrenata passione per lettura e letteratura autografata dall’arbitro imparziale Paolo Nori.
Baldini fu un poeta dialettale riconoscibile nelle liriche imbevute di saggia ironia per sfuggire al paternalismo invisibile del tempo.
Le stesse liriche che Baldini traduceva in lingua italiana accessibile a tutti, ma che a volte non raggiungono il fine ultimo dell’originario progetto. Il dialetto corre veloce, per qualche secondo la lingua invece trattiene il fiato prima di realizzare qual è stato l’incentivo del disegno. Il poeta Baldini riconosce il peso della solitudine, lo interroga con l’ ironica schiettezza tipica del dialetto fruibile a tutti. Di questo labirinto solitario Nori ne ha piena consapevolezza, tanto da condurre Baldini nel suo affresco narrativo come nobile ospite dell’elaborazione stereotipata di un racconto.
Non è la prima volta.
Da “Sanguina ancora” di Dostojevskij (Mondadori 2021), a “Vi avverto che vivo per l’ultima volta” di Anna Achmatova (Mondadori 2023) Paolo Nori avverte l’esigenza di una prestigiosa connessione letteraria che sia fervente impulso motivazionale contrapposto all’espressione mite del limite personale.
“Come non mi stanco di dire, una cosa che mi piace, di Tolstoj, di Dostoevskij, di Anna Achmatova, di Raffaello Baldini, della letteratura, è il fatto che mi fanno vedere le cose che sono in casa mia, che mi circondano, come se le vedessi per la prima volta, non rendono visibile l’invisibile, rendono visibile il visibile. Che è una cosa, uno potrebbe pensare, se è visibile, che bisogno c’è di renderlo visibile?”
Gli uomini soli conoscono se stessi quando sono anima confinante con altro uomo pronto a schivarti dal pericolo.
Il primo domanda, il secondo risponde. Il poeta si affida alle virgole senza le quali i versi soffrirebbero del tempo in attesa di segni di interpunzione sinonimi di epilogo provvisorio. Nori scrittore e blogger di questo tempo scrive spedito evitando le curve tipiche dell’immagine poetica che forse non ha mai incontrato. Le sue pagine ospitano altre sensibilità trattate con deliziosa cura da chi ha letto un cuore senza avvertirne presenza. Nori esprime gratitudine al poeta maestro di incontri con la parte più leggera di sè a conferma della virtù sensoriale dell’arte poetica. Baldini esaltava (con ironia) il modo migliore per vivere senza contare i passi. Tutte le premure visibili venivano allontanate da fantasmi alleati sotto falsa copertura. A questo punto Nori pretende che sia proprio lui il passeggero ufficiale del romanzo salito sul treno ancora fermo sui binari. Arriveranno insieme al traguardo ma con valigie di peso diverso. L’ avventura condivisa ha tradotto l’urgenza della parola nell’ascolto di promesse precoci sulla verità.
“Il mondo ha bisogno, di esser bello e, io non sono sicuro che il mondo si salverà, ma, se mai si dovrebbe salvare, io non voglio avere ragione, ma se si dovrebbe salvare, il mondo, mi sembra così evidente, lo salverà la bellezza.
È un processo insolito, che talvolta si compie in un attimo come per una specie di choc liberatorio: l’uomo si sbarazza della paura e si sente libero. Senza questo processo non ci sarebbe alcuna rivoluzione”.
Paolo Nori ripete l’immagine in bianco e nero del caffè letterario, il caffè Trieste, gestito dai genitori del poeta Baldini. L’ ordine del giorno coniugava politica, letteratura, cinema, musica, tutti temi alleggeriti da esercitazioni manuali nei giochi oggi non più nel mondo. La passione si spingeva oltre i confini dei salotti riservati a “signora cultura”.
Nacque così un gruppo impegnato nella sperimentazione di nuove forme d’arte.
Negli anni ’60 e ’70 a Santarcangelo di Romagna scrittori, poeti, sceneggiatori, scultori risorti del dopoguerra sedevano attorno a un tavolo con un ritrovato respiro.
Nino Pedretti, Flavio Nicolini, Tonino Guerra, Raffaello Baldini, Renzo Vespignani furono solo alcuni membri del Circolo del Giudizio. In un piccolo paese di dodicimila abitanti emersero promotori di laboratori di arte e letteratura a ragione di un nuovo vento intellettuale.
Ci sono storie che cominciano in silenzio, davanti a un caffè. Quella dell’emancipazione culturale di cui parliamo è una di queste, e una riflessione di Paolo Nori sarebbe preziosa per comprenderla pienamente.