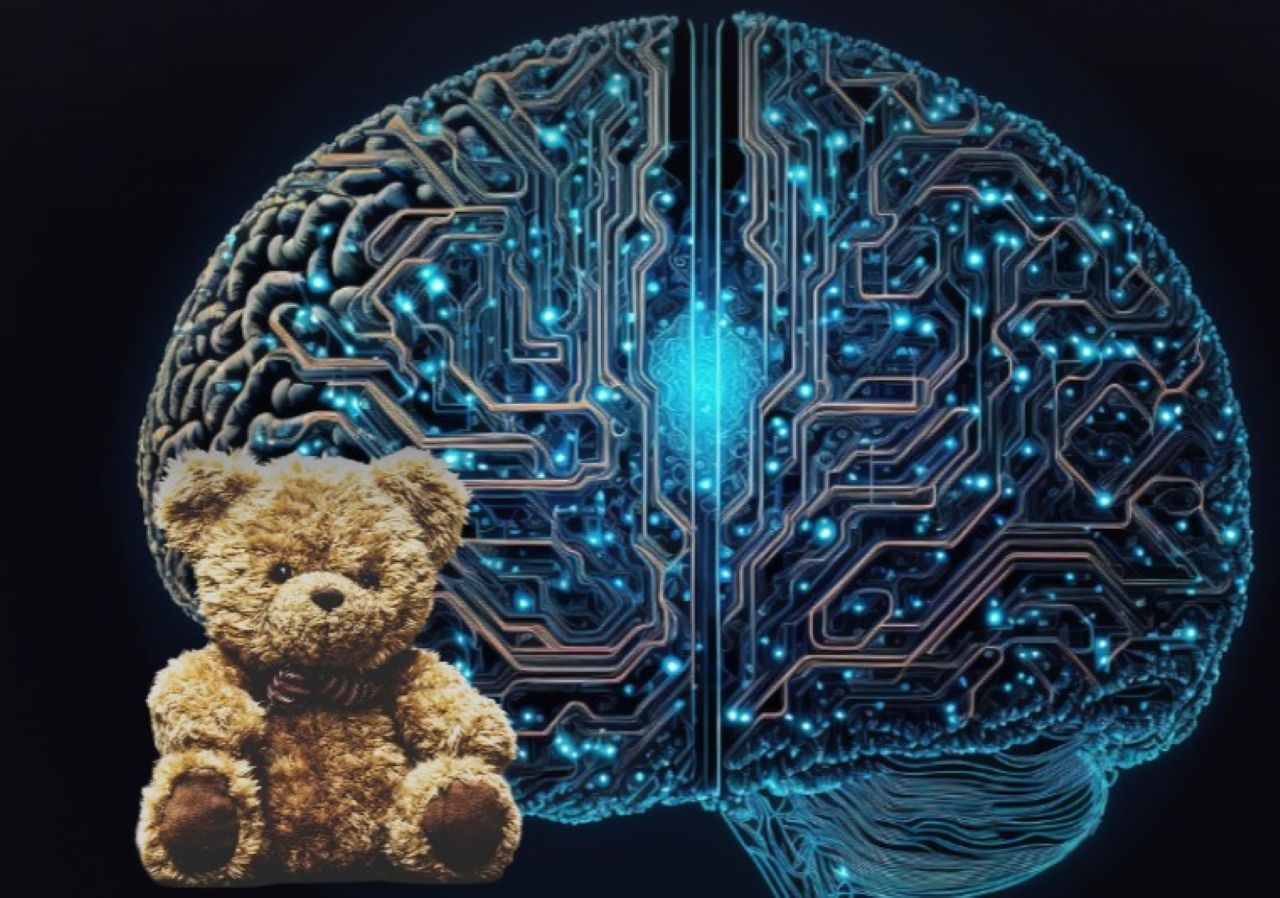Immaginate i vostri figli che, tutto d’un tratto, non vi chiedono più di leggere loro una storia. Immaginate i vostri piccoli che smettono di “bombardarvi” di innumerevoli “perché“, domande che mostrano la sete di curiosità e di conoscenza di un mondo a loro ignoto. Immaginate che un giocattolo usurperà il vostro ruolo a riguardo, quegli atteggiamenti che a volte possono risultare scoccianti ma che il loro sorriso e la loro gioia annullano. Non manca molto affinché questo possa concretizzarsi.
I giocattoli AI che “bussano” alla porta dei bambini
Sta crescendo a ritmi sostenuti il mercato dei giocattoli intelligenti, cioè dispositivi con intelligenza artificiale integrata: lo si evince dai dati di Future Market Insights, le cui previsioni parlano di una crescita del 14% annuo fino al 2034; il mercato globale dei giocattoli tradizionali resta sostanzialmente piatto (con un calo dello 0,6% nel 2024).
Emergono diversi esempi di giocattoli smart: il più lampante è l’orsacchiotto di Grok, sviluppato dalla start-up Curio, che integra l’intelligenza artificiale di OpenAi per dialogare con i bambini.
L’obiettivo, secondo quanto si apprende, è quello di ridurre la dipendenza da smartphone e tablet, offrendo opportunità di gioco interattivo fisico. E ancora, robot che camminano insieme ai bimbi – tra questi spicca WowWee MiP, che comunica attraverso una sua lingua inventata – o ciondoli con intelligenza artificiale da appendere ai peluche.
Certamente non tutto è oro quel che luccica: questi giocattoli non sono esenti da comportamenti inappropriati e potenzialmente pericolosi. Ad esempio, OpenAI ha bloccato ai bambini l’orsacchiotto Kumma, che non aveva filtri adeguati all’età, arrivando a conversare su pratiche sessuali o altri argomenti spinti per un bambino in una fase delicata dello sviluppo cognitivo.
Il rapido cammino verso la passività cognitiva: ne parliamo con il dottor Simone Varrasi
Viviamo in un momento segnato da una rivoluzione tecnologica e massmediologica che ha, volente o nolente, modificato pratiche educative e comportamenti dei più piccini.
Dall’utilizzo dello smartphone già in età molto tenera (sono numerosi i genitori che fanno giocare o mostrano video ai figli di 2/3 anni con il proprio cellulare) alla recente evoluzione del mondo dei giocattoli. Dinamiche che, nel bene e nel male, possono avere un impatto significativo sullo sviluppo dei bambini, ad esempio sull’attenzione, sulla diminuzione della lettura su supporto cartaceo, o sulla dipendenza dagli schermi.
Nell’era di “ChatGpt” la passività cognitiva è un rischio concreto e non è così difficile andare in contro a superficialità e annullamento della capacità critica. E se per gli adulti è un pericolo, per i più piccoli l’allarme è drammaticamente amplificato. Motivo per cui noi di NewSicilia abbiamo chiesto al dottor Simone Varrasi – psicologo, psicoterapeuta e assegnista di ricerca all’Università di Catania – di intervenire ai nostri microfoni, spiegando perché il rischio è così concreto e quali potrebbero essere le strategie per fronteggiare questa nuova sfida educativa.
-
Questa rivoluzione del mondo dei giocattoli potrebbe portare a una passività nel bambino? Se sì, quali i rischi nelle relazioni sociali (considerando che i piccoli inizierebbero a “comunicare” con un giocattolo che risponde alle domande)?
L’esperto ha messo in evidenza come il tutto dipenda dall’impostazione del gioco. “Il bambino diventa più passivo se il giocattolo guida e controlla troppo l’attività, ad esempio fornendo stimoli eccessivi o anticipando le risposte. Questo può ridurre anche i livelli di gioco simbolico – attività fondamentale attraverso cui il piccolo struttura il pensiero – e le interazioni con l’adulto”.
Diversi sono gli studi – sottolinea il dottor Varrasi – che segnalano “come i bambini parlino meno quando interagiscono con un giocattolo parlante, rispetto a quando interagiscono con lo stesso gioco in versione non elettronica. Bisognerebbe, dunque, integrare le nuove tipologie di giocattoli in interazioni sempre mediate da adulti o condivise con i pari, in cui i punti fondamentali restino il rapporto sociale con l’umano, la stimolazione dell’esplorazione e la promozione dell’interazione attiva“.
-
Prendiamo l’esempio di un bimbo che chiede alla mamma o al papà di leggergli una storia: che ruolo gioca la presenza fisica del libro e fino a che punto un robottino o una bambola che racconta storie può cambiare – o compromettere – questa esperienza?
La lettura condivisa, ha spiegato l’esperto, è certamente “una delle attività più stimolanti sul piano affettivo e cognitivo. La presenza fisica del libro e dell’adulto garantiscono uno scambio relazionale (fatto di intonazione, contatto visivo, commenti spontanei), adatto continuo del linguaggio al livello del bambino e creazione di un’abitudine rassicurante”.
Ebbene, un orsacchiotto “intelligente” possono sicuramente “raccontare una storia e stimolare la curiosità, ma verrebbe a mancare la dimensione affettiva e di regolazione emotiva“. Anche se non esistono prove su eventuali danni che ascoltare una storia da uno strumento artificiale potrebbe provocare, “l’esperienza che ne deriva è senz’altro meno completa”.
-
È molto diffuso l’utilizzo di smartphone o tablet tra i bambini – persino a 2-3 anni – per calmarli: quali gli impatti a livello cognitivo?
Tocchiamo adesso un tasto più che dolente, una “pratica” molto diffusa tra i neogenitori: prestare il loro smartphone o persino comprare un tablet ai loro figli durante la prima infanzia. Comportamento che, senz’ombra di dubbio, non è esente da impatti a livello cognitivo-emotivo.
Lo psicologo ha messo in evidenza il fatto che il problema “non è lo strumento in sé ma la funzione regolatoria che assume: il rischio è che il bambino non sviluppi adeguatamente capacità autoregolatorie nei confronti delle emozioni (ad esempio della frustrazione), o che possa avere difficoltà a mantenere in modo spontaneo buoni livelli di attenzione sostenuta, poiché costantemente sottoposto agli stimoli veloci e intensi degli schermi”.
“È bene sottolineare che non è pericoloso l’uso occasionale delle tecnologie, ma piuttosto che queste possano sostituirsi alla relazione con l’adulto: infatti è solo attraverso la relazione con una figura di riferimento competente che è possibile imparare a calmarsi e a gestire le emozioni in modo efficace”.
-
E l’intelligenza artificiale? Quali potrebbero essere i rischi – a livello di attenzione, apprendimento – se un bambino di scuola elementare iniziasse a usare ChatGPT per porre gli innumerevoli “perché” ai quali, generalmente, rispondono i genitori.
E se un bambino usasse ChatGpt? La domanda viene spontanea e il dottor Varrasi riflette qualche secondo prima di rispondere.
“L’intelligenza artificiale può essere una risorsa educativa, ma nel caso dei bambini di scuola elementare dobbiamo porre particolare attenzione. È chiaro, ad esempio, che le risposte di un’intelligenza artificiale potrebbero essere troppo complesse, non contestualizzate e non adattate all’età di chi pone le domande, in quanto i modelli linguistici non calibrano automaticamente i loro feedback al livello di sviluppo dell’interlocutore”.
“Possiamo inoltre affermare che un loro uso esclusivo ridurrebbe le interazioni del bambino con l’adulto, con un possibile effetto sul legame affettivo, che di per sé è già un potente stimolatore cognitivo. Infine, ricevere risposte già pronte eliminerebbe la ricerca spontanea e la curiosità che di norma il bambino esercita con le sue esplorazioni graduali e i suoi ‘perché’. Anche qui il problema non è l’intelligenza artificiale in sé, ma il fatto che si sostituisca all’interazione con l’adulto o al processo di costruzione delle conoscenze attraverso l’esperienza diretta”.
-
Quali strategie, a suo avviso, possono essere messe in atto per aiutare i bambini a crescere senza rinunciare ai benefici dell’innovazione?
È fondamentale che, in tal senso, l’adulto partecipi, commenti, spieghi e guidi. Così, secondo lo Psicoterapeuta, si ottiene il beneficio maggiore. “In questo modo l’uso della tecnologia può essere integrato nella relazione, e non sostituito ad essa. È opportuno inoltre non usare gli schermi come strumenti calmanti, in quanto le strategie di autoregolazione sono fondamentali per tutto il corso della vita e vengono apprese proprio da piccoli attraverso gli scambi con gli adulti, con i pari e con il gioco“.
“È opportuno prevedere regole semplici e coerenti per l’uso degli strumenti digitali, ad esempio durata breve, orari stabili e supervisione costante. Non bisogna pensare che l’innovazione sia un pericolo, ma anzi cogliere ogni occasione per introdurre fin da piccoli un’educazione digitale, che possa permettere un uso sempre più consapevole delle nuove tecnologie”.