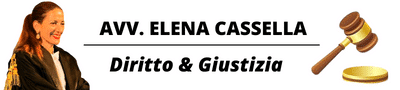La libertà è un valore fondamentale, spesso discusso sia come diritto di non subire condizionamenti sia come possibilità di realizzare le proprie aspirazioni. Tuttavia, nella società, la libertà di ognuno incontra limiti laddove inizia quella degli altri, un principio essenziale per la convivenza civile. Questo tema si fa particolarmente urgente durante l’adolescenza, quando il bisogno di autonomia si manifesta con forza.
Ma cosa accade quando la libertà personale viene limitata? E quali sono le funzioni e le criticità del nostro sistema carcerario?
Questo sarà il tema centrale dell’incontro promosso dall’Istituto Liceo Classico, Nicola Spedalieri che ivi si terrà giorno 11 ottobre 2025, e avrà come relatore il Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Catania, dott. Sebastiano Ardita, già Direttore Generale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
Fin dall’antichità, il potere dominante ha limitato la libertà personale per motivi diversi: dalla reclusione dei folli nei manicomi agli schiavi, dai prigionieri di guerra ai lebbrosari medievali. Nel caso dei criminali, la prigione serviva principalmente a isolare i soggetti “pericolosi”, non tanto a punirli quanto ad allontanarli dalla società.
Storicamente, le pene erano spesso corporali: mutilazioni, torture e, nei casi estremi, la pena capitale. Il loro scopo era dissuadere con la paura e la crudeltà, ma nel tempo, soprattutto durante l’Illuminismo, queste pratiche sono state messe in discussione. Le esecuzioni pubbliche, infatti, si rivelavano controproducenti, suscitando talvolta simpatia per il condannato e alimentando rivolte popolari.
Con l’Illuminismo e la nascita dello Stato di diritto, la pena detentiva sostituisce progressivamente le punizioni corporali. La legge diventa uno strumento di prevenzione e reinserimento, non di vendetta. Secondo lo studioso Michel Foucault, la pena deve essere certa, proporzionata e mirata anche a prevenire il crimine nella collettività, oltre che nel singolo individuo. Si afferma così il principio della rieducazione del condannato.
La Costituzione italiana tutela la libertà personale come diritto fondamentale (art. 13), limitabile solo nei casi previsti dalla legge. La pena detentiva, oggi, ha quattro funzioni principali:
- Rieducativa (o riabilitativa): Favorire il reinserimento sociale e lavorativo del detenuto, come previsto dall’art. 27 della Costituzione.
- Retributiva: Infliggere un castigo proporzionato al reato commesso.
- Prevenzione generale: Agire come deterrente per la collettività.
- Prevenzione speciale: Impedire al condannato di commettere nuovi reati e favorirne la riabilitazione.
Quali sono le criticità del sistema carcerario italiano?
Un recente servizio di Focus ha portato alla luce gravi criticità: sovraffollamento, aumento dei suicidi e difficoltà nel reinserimento dei detenuti. Nonostante il carcere dovrebbe rieducare, i dati mostrano altro: il 60% dei detenuti torna a delinquere, mentre la recidiva scende al 2% tra coloro che hanno avuto un’opportunità lavorativa.
Questi numeri dicono molto: il vero problema del sistema penitenziario non è soltanto la criminalità, ma l’inefficienza nel fornire strumenti concreti per il reinserimento. Lavorare durante la detenzione si conferma il fattore chiave per abbattere la recidiva e offrire una possibilità reale di cambiamento.
Per concludere
Il carcere, nella sua evoluzione storica, dovrebbe oggi essere luogo di recupero e reinserimento, non solo di punizione. Le criticità che affliggono il sistema italiano, però, mettono a rischio questo obiettivo. Investire nel lavoro e nella formazione dei detenuti non è solo una questione di giustizia, ma una necessità per una società più sicura e inclusiva. La libertà, anche per chi l’ha persa, può (e deve) tornare a essere un valore da riconquistare.