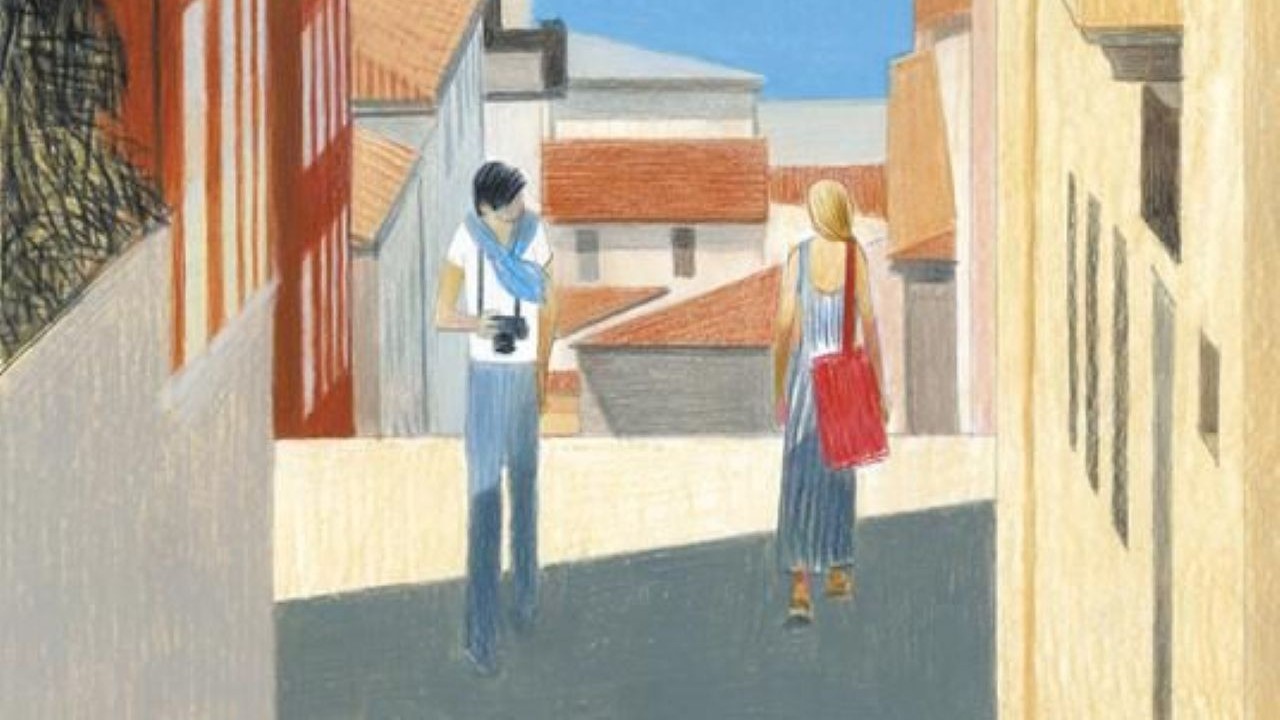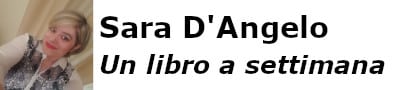Siamo tutti figli legittimi della terra che ci ha tenuto nel suo grembo, siamo e saremo per sempre figli dei luoghi che ci hanno accolto nel lungo viaggio di ritorno nel nostro centro. Culla, origine, radice.
Questo è quanto succede ad Alma, figlia della città di Trieste emigrata nella capitale, una donna carica di valigie ingombranti di storia personale e non solo. Della sua vicenda se ne prende cura Federica Manzon, il cui romanzo si sdoppia nella rete dei confini geografici intrecciati all’identità acrobata del passo indietro.
Alla morte del padre Alma ritorna nella sua Trieste, città natale custode di memorie impastate con gli eventi nefasti di una guerra come vicina di casa. Per Federica Manzon il dovere di riferire il martirio del conflitto dei Balcani, la dittatura del maresciallo Tito (occhi di vipera) riversa in una tensione narrativa palpabile, conta più della descrizione dei protagonisti distesa a fianco delle armi a servizio del male.
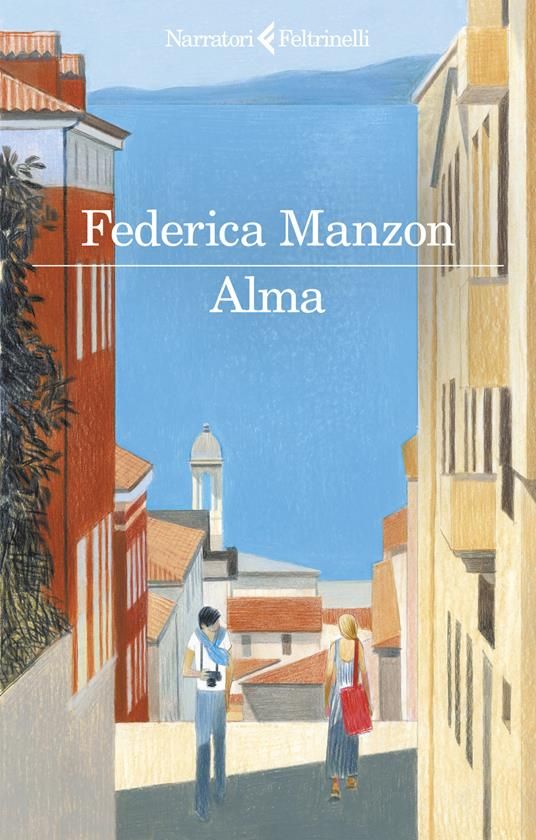 “La città è sempre stata vasta sopra le loro vite, sua e di suo padre e di Vili: un punto di attrazione che li ha spinti a tormentarsi, scappare e tornare, alimentando il sospetto in chi li amava di essere solo un incidente funzionale al legame con la città, che dal canto suo ha sempre brillato in questa vocazione – rendere impossibile il restare e lacerante il partire“.
“La città è sempre stata vasta sopra le loro vite, sua e di suo padre e di Vili: un punto di attrazione che li ha spinti a tormentarsi, scappare e tornare, alimentando il sospetto in chi li amava di essere solo un incidente funzionale al legame con la città, che dal canto suo ha sempre brillato in questa vocazione – rendere impossibile il restare e lacerante il partire“.
Alma risponde all’appello come legittima erede del padre, un uomo sempre in viaggio oltre il confine italiano, vicino a una Jugoslavia non ancora ex. La ragione dei suoi spostamenti è mantenuta segreta con tutto il peso emotivo in chi non riesce a leggere il disagio.
Nella sua casa sul Carso, Alma ritrova qua e là le tessere di un puzzle abbandonato prima di dar loro la compiutezza che meritano. La casa materna circondata dai platani, gli storici caffè in cui sedevano i padri della letteratura e della poesia come Svevo, Saba, Joyce. Spazi disseminati “dove le persone entravano e se ne andavano, e pareva che i vestiti non fossero mai stati tolti dalle valigie“.
La prima eredità acquisita di Alma è la città di Trieste, una cornice familiare di protezione per i processi labili della vita. La città dai palazzi bianchi non riuscirà a sfiammare le polveri della barriera tra italiani e milioni di profughi sloveni senza un tozzo di pane in tasca.
A Trieste Alma ritrova Vili, l’uomo incontrato da souvenir umano poi dimenticato sul mobile vintage perché la sua presenza rinnova un dolore. Ancora. Vili, ragazzino figlio di dissidenti al regime di Tito fu portato in casa dal padre di Alma nel silenzio di una notte senza occhi. Vili conosce segreti che negli anni diventeranno conflitti tra Alma e quel giovane sempre meno fratello, sempre più nodo d’amore contrastato da un tunnel a porte chiuse.
“Alma non si è mai chiesta se a spingerla ogni volta verso Vili fosse il fatto che lui veniva dalla parte del mondo a cui apparteneva suo padre e che per lei significava fantasmi e desideri, oppure il fatto che, anche se per ragioni diverse, sentiva che condividevano un’uguale irrequietezza, il bisogno di non dare conto delle proprie intenzioni e andarsene. Lo avrebbe amato lo stesso se lui non fosse stato l’esiliato del Danubio?”
Alma dovrà lottare, e molto, per risalire fino al saldo dei misteri irrisolti del padre. La sua fuga nella Capitale chiude in valigia parole di due lingue diverse, perciò incomprensibili nella traduzione responsabile di macchie indelebili.
Sono solo tre i giorni impiegati nel viaggio a ritroso del dramma storico alternato a soluzioni personali, tre i giorni della Pasqua ortodossa che rievocano memorie di luoghi e presenze sfuggenti, per prima quella del padre di Alma di professione girovago cantastorie oltre il confine. Le rare e brevi pause lo riportavano a casa insieme ai suoi segreti rivelati a nessuno.
“In quel momento aveva realizzato che suo padre non le aveva raccontato niente di sé, solo qualche contorto frammento del Paese in cui era cresciuto e che ora non esisteva più, e lei sapeva cosa significa perdere un’occasione o anche una persona, ma non cosa significa perdere un Paese. Ecco la domanda che avrebbe dovuto fare a suo padre. Si era girata per cercarlo di nuovo, ma dalla stazione avevano chiamato il suo treno e lei aveva lasciato perdere. Quella era l’ultima volta che l’aveva visto”.
Alma lo sa bene che indietro non si può tornare, adesso però la visione dei luoghi che un tempo furono casa riaccende memorie avviate alla reclusione forzata. Alma resta comunque anello di catena vincolata al germe dell’appartenenza, sebbene il tempo abbia accettato un compromesso con il desiderio di libertà.
Da competente maestra di pagine a senso inverso, Federica Manzon interroga il passato a riposo nei libri depositari di una guerra ai confini della lingua italiana. E lo fa con una scrittura delicata per non far male agli occhi che ritornano negli anni del conflitto dei Balcani. È chiara la volontà di munire la sua musa di un’anima meccanica in pieno sorvolo su contesti intrappolati negli scatti storici.
Il saggio un po’ romanzo vincitore della 62esima edizione del Premio Campiello si assume la responsabilità di restituire un ponte narrativo tra passato e le grandi sfide in serio pericolo del presente. In un posto nel mondo c’è un allarme sempre attento a schivare le ire dell’ora furente.