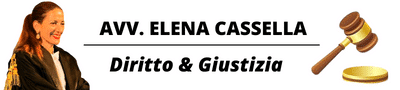CATANIA – Nel contesto sociale e culturale italiano, il termine “femminicidio” ha assunto una forte valenza simbolica e mediatica, pur in assenza di una definizione giuridica autonoma nel Codice penale. Nonostante ciò, il legislatore ha progressivamente costruito un articolato impianto normativo volto a riconoscere la gravità dei reati commessi contro le donne, in particolare nei contesti relazionali, affettivi e familiari.
Il delitto di femminicidio come autonoma fattispecie criminosa
Il panorama normativo del cosiddetto “Codice Rosso” – introdotto con la legge 19 luglio 2019, n. 69 – ha subìto negli ultimi anni una significativa evoluzione, con l’introduzione di nuove fattispecie criminose e il rafforzamento degli strumenti di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. All’impianto originario della legge n. 69/2019 si sono successivamente aggiunti interventi normativi mirati, che hanno arricchito e potenziato le misure di protezione.
Tra le principali novità del Codice Rosso, particolare rilievo assume l’introduzione dell’art. 612-ter del codice penale, che ha tipizzato il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, noto come “revenge porn”. Significativa anche l’introduzione dell’art. 558-bis c.p., che punisce la costrizione o induzione al matrimonio con la reclusione da uno a cinque anni. Sul versante processuale, l’art. 387-bis c.p. sanziona la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in attuazione dell’art. 53 della Convenzione di Istanbul.
Attualmente è all’esame parlamentare il disegno di legge n. 1433, che introduce il delitto di femminicidio come autonoma fattispecie criminosa, con l’obiettivo di ampliare la tutela già prevista dal Codice Rosso. La proposta, approvata all’unanimità dal Senato lo scorso 23 luglio e ora all’esame della Camera, ha riacceso il dibattito dottrinale: ha senso punire un reato in modo differente sulla base del genere?
Il tema divide. Secondo alcuni, l’asimmetria normativa risponde a una realtà sociale innegabile, dato che la maggioranza delle vittime di violenza domestica e relazionale sono donne. Secondo altri, invece, la nuova norma rischia di inserirsi in modo disarmonico nel Codice Rosso e di utilizzare la leva penale più come strumento simbolico che come presidio ultimo a tutela del bene giuridico protetto.
Tra le obiezioni più frequenti, spicca quella relativa all’effettiva deterrenza del disegno di legge e alla previsione della pena dell’ergastolo. Chi commette questi reati sarebbe infatti mosso da dinamiche di possesso o dominio patriarcale, che si manifestano come una forza superiore rispetto alla vittima, rendendo poco efficace la minaccia della pena.
L’approfondimento tecnico-giuridico del Procuratore Ardita
Abbiamo chiesto al Dott. Sebastiano Ardita, magistrato antimafia e Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Catania, di condividere il suo punto di vista, attraverso un approfondimento tecnico-giuridico, sull’introduzione di questa fattispecie di reato.
Procuratore Ardita, a suo parere, l’evoluzione normativa dal Codice Rosso al disegno di legge AS 1433 sul femminicidio risponde effettivamente a esigenze di tutela sostanziale, oppure rappresenta piuttosto una risposta simbolica alle pressioni dell’opinione pubblica?
“A mio avviso, l’evoluzione normativa dal Codice Rosso al disegno di legge AS 1433 costituisce certamente una risposta alle esigenze di tutela, ma riflette anche la necessità di offrire risposte simboliche alle sollecitazioni dell’opinione pubblica. Il Codice Rosso, infatti, ha segnato un momento importante, ponendo l’attenzione su condotte che in passato venivano spesso derubricate a semplici percosse e perseguite solo su querela. L’introduzione di etichette specifiche per questi reati e la previsione di tempistiche più stringenti per l’intervento della giustizia hanno sicuramente avuto un impatto positivo. Tuttavia, bisogna riconoscere che il bilancio dei risultati è, ad oggi, modesto, raggiunto spesso a fronte di sacrifici notevoli dal punto di vista del sistema giustizia”.
In tema di “doppio binario” processuale, ritiene che tale meccanismo sia realmente efficace per la repressione dei reati di violenza di genere?
“Il doppio binario trova la sua ragion d’essere soprattutto nei confronti di organizzazioni criminali complesse, dove è necessario utilizzare strumenti processuali particolari per non compromettere l’efficacia dell’azione giudiziaria. Quando invece si tratta di fenomeni legati alle scelte e ai comportamenti del singolo, tale strumento serve principalmente a dichiarare un maggiore rigore dello Stato verso certe condotte, più che a garantire una concreta efficienza repressiva”.
Dal punto di vista della tecnica legislativa, come valuta l’inserimento del femminicidio quale fattispecie autonoma nel sistema penale già disciplinato dal Codice Rosso?
“L’introduzione del femminicidio come fattispecie autonoma appare, dal punto di vista tecnico, distonica rispetto all’impianto codicistico esistente, in quanto si finisce per qualificare diversamente un fatto sostanzialmente identico solo in ragione del genere della vittima. Tuttavia, non si può trascurare che proprio il genere rappresenta, nella cultura sottesa alla norma, un elemento determinante. Il dibattito sull’asimmetria nasce dal riconoscimento di una vulnerabilità strutturale delle donne nei contesti di violenza domestica, dato statisticamente incontrovertibile. Ciò non toglie che la risposta penale non possa risolvere da sola un problema sociale così complesso, né che la proliferazione delle fattispecie sia sempre la soluzione più efficace”.
Considerando che questi reati hanno spesso natura impulsiva, quanto può essere efficace la pena dell’ergastolo nel prevenire il femminicidio? Sarebbe più utile puntare su misure terapeutiche obbligatorie?
“L’introduzione del femminicidio come fattispecie autonoma e l’inasprimento delle pene, fino all’ergastolo, non producono un significativo effetto deterrente sugli autori di questi reati, proprio per la loro natura prevalentemente impulsiva e irrazionale. La realtà della prassi penitenziaria, inoltre, mostra che l’ergastolo raramente si traduce in una detenzione perpetua effettiva, e le misure alternative portano a una reclusione effettiva spesso inferiore ai 20 anni, anche per i reati più gravi. L’approccio più efficace dovrebbe essere quello di investire su interventi terapeutici volti a modificare i modelli comportamentali e culturali che alimentano la violenza, piuttosto che puntare solo sull’inasprimento delle pene”.
Alla luce della giurisprudenza che riconosce la natura strutturale della violenza di genere come “manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi”, quali strumenti ritiene possano contribuire a modificare gli equilibri di potere che alimentano il fenomeno del femminicidio? In particolare, come valuta il potenziale degli strumenti di controllo elettronico e delle tecnologie di protezione nel ridurre la forza fisica come fattore determinante nella violenza domestica?
“La forza fisica rimane ad oggi uno dei fattori più determinanti nel fenomeno del femminicidio, ma non è l’unico: l’asimmetria riguarda anche il piano psicologico ed economico. La prospettiva, tuttavia, è quella di una progressiva neutralizzazione del fattore “forza fisica” come elemento di supremazia, grazie all’impiego crescente di strumenti tecnologici di protezione e controllo elettronico. Si tratta di una rivoluzione in atto, in grado di garantire una maggiore parità di accesso alla sicurezza e alla protezione, contribuendo così a scardinare uno dei pilastri su cui si fonda la violenza di genere“.